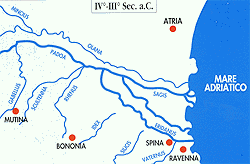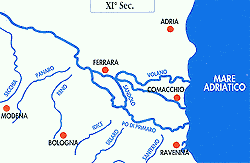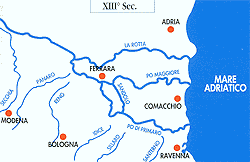Il delta del Po
Il delta del Po con la sua forma caratteristica a "zampa
d'oca" ha una superficie di 400 kmq. circa, si espande sull'Adriatico al
ritmo di 60-70 mt all'anno grazie al continuo apporto di materiali alluvionali.
Quest'area comprende anche vaste depressioni, costituenti territori di bonifica,
d'acqua salmastra il cui sfruttamento é limitato alla piscicoltura, oltre a
spazi lagunari, ossia insenature del fiume isolate dal mare dette
"valli" o marini detti "sacche". Soprattutto nell'interno si
possono trovare delle file di dossi chiamati "scanni", rialzati al
massimo una decina di metri, piani o leggermente montagnosi.Questi lidi
sabbiosi, che il mare è venuto costruendo con gli stessi apporti del fiume,
permettono di fissare gli stadi attraverso i quali é passata la formazione del
delta, o meglio dei delta, costituenti la foce del Po. Questi delta, tutti
esterni alla linea delle lagune, sono probabilmente d'epoca storica.Questi
rami deltizi alimentano a loro volta quattordici bocche, ed i due mediani della
Pila e di Tolle sono i più attivi. Il Delta padano nel corso della sua storia
geologica ha modellato una zona costiera molto più ampia di quella attuale,
costruendo una fascia che si estende da Chioggia a Ravenna, per una profondità
di 20-30 Km. L'apparato deltizio ha subito profonde trasformazioni storiche sia
in seguito alle grandi piene, ad esempio la famosa "rotta" degli
argini presso Ficarolo a nord di Ferrara, ed alla normale azione erosiva delle
acque, accompagnata da fenomeni bradisismici, sia a causa delle grandi
sistemazioni idrauliche operate nel passato. Cito fra tutte quelle della
Repubblica Veneta che all'inizio del XVII secolo (1600-1604) fece eseguire il
grandioso "taglio" di Porto Vico in grado di portare il fiume a
sboccare più a sud onde evitare l'interramento della laguna veneta, dovuto ai
depositi di sabbia e limo. Il recupero dei terreni paludosi ("valli")
a fini agricoli è stato realizzato nei lustri a cavallo del 1900, ma gli
indubbi vantaggi conseguiti furono in parte pagati con la scomparsa d'un
ambiente ecologicamente preziosissimo (il Po di Maistra è l'unico ramo fluviale
del Delta che ancora offre aspetti naturalistici di rilievo), e con una maggior
rigidità della struttura di deflusso che ha determinato l'avanzamento della
foce fluviale. Il fiume contenuto tra argini imponenti per proteggere le
coltivazioni, non riesce più a distribuire nella pianura i sedimenti e li
accumula nel suo alveo e alla foce innescando un circolo vizioso: più alti
diventano gli argini, più i sedimenti innalzano il fondo, richiedendo argini
ancora più alti. Tutto il corso del Po è negli ultimi 410 km (a valle della
confluenza del Ticino), imbrigliato entro argini. Negli ultimi 50 anni però
l'avanzata del delta ha subito un'inversione, soprattutto in seguito
all'abbassamento della fascia costiera (subsidenza) causato dal prelievo
massiccio di acqua e metano dal sottosuolo. L'estrazione del metano, durata fino
ai primi anni sessanta, ha abbassato il delta di due o tre metri; questa è
considerata una delle cause delle catastrofiche alluvioni di quegli anni. Oggi a
causa della costipazione dei terreni bonificati e delle selvagge estrazioni di
metano, degli anni cinquanta e sessanta, il delta è una terra completamente al
di sotto del livello del mare. Si può suddividere in due parti, una parte a
nord protesa nell'Adriatico per chilometri, e formata dai rami attivi del Po, e
la parte a sud del Po di Volano attraversata dai corsi d'acqua che scendono
dall'Appennino, come il Lanone e il Reno. Le vaste zone umide presenti qui (come
le Valli di Comacchio) sono soltanto i resti di quegli immensi acquitrini che
coprivano l'area fino al secolo scorso. Oggi si ritiene che sia importante
conservare le "zone umide", nelle quali vivono piante e animali che
non si trovano in altri ambienti, ed il delta è l'unica zona in cui
l'ecosistema viene ancora regolato in parte da fattori naturali. Specie rare in
Italia, come la "beccaccia di mare", la "volpica" e la
"spatola", si possono osservare in quest'area; qui nidifica anche la
maggior parte degli "aironi rossi". Nella metà di delta a nord del Po
di Venezia, però, si incontrano sterminate estensioni d'un altro ambiente
eccezionale: le valli da pesca. Si tratta di grossi bacini di acque salmastre
poco profonde il cui regime idrico è regolato dall'uomo per l'allevamento del
pesce. 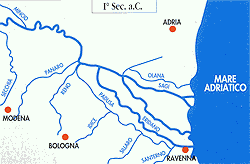 Come
abbiamo detto il Po è il più grande fiume italiano, che sfocia nel mare
Adriatico determinando l'articolato sistema territoriale del suo delta, e snoda
il suo corso per oltre 650 Km (è impossibile infatti definirne con precisione
la lunghezza, per l' incessante lavoro di modifica delle dimensioni
dell'apparato deltizio messo in opera dal fiume stesso, dal mare e da altri
agenti naturali ed artificiali). Infatti il grande Fiume non è stato sempre così;
al contrario, come accade quando l'acqua è uno degli elementi portanti della
morfologia di una regione geografica, la mutevolezza dei luoghi è stato il
tratto saliente di questo paesaggio, che nel corso degli ultimi millenni si è
radicalmente trasformato per l'azione di molteplici fattori (la dimensione
quantitativa degli apporti di detriti, il clima, l'attività eolica, la
subsidenza dei suoli, la forza di condizionamento espressa dagli affluenti e dal
mare stesso, ecc.). Con il tempo, i confini tra l'emerso ed il sommerso sono via
via mutati, ed il territorio è stato letteralmente costruito ed ha assunto una
relativa stabilità. Nell'ambito del Ferrarese e del contiguo comprensorio
padano del Rodigino, verso la fine dell'Età del Bronzo il corso del fiume si
articolava in due rami principali, il Po di Adria ed il Po di Ferrara, che
sviluppava poi diverse diramazioni nella zona orientale. Il progressivo apporto
di materiali allungava la pianura paludosa e spostava progressivamente verso Est
la linea di costa, attestando successivi cordoni dunosi.
Come
abbiamo detto il Po è il più grande fiume italiano, che sfocia nel mare
Adriatico determinando l'articolato sistema territoriale del suo delta, e snoda
il suo corso per oltre 650 Km (è impossibile infatti definirne con precisione
la lunghezza, per l' incessante lavoro di modifica delle dimensioni
dell'apparato deltizio messo in opera dal fiume stesso, dal mare e da altri
agenti naturali ed artificiali). Infatti il grande Fiume non è stato sempre così;
al contrario, come accade quando l'acqua è uno degli elementi portanti della
morfologia di una regione geografica, la mutevolezza dei luoghi è stato il
tratto saliente di questo paesaggio, che nel corso degli ultimi millenni si è
radicalmente trasformato per l'azione di molteplici fattori (la dimensione
quantitativa degli apporti di detriti, il clima, l'attività eolica, la
subsidenza dei suoli, la forza di condizionamento espressa dagli affluenti e dal
mare stesso, ecc.). Con il tempo, i confini tra l'emerso ed il sommerso sono via
via mutati, ed il territorio è stato letteralmente costruito ed ha assunto una
relativa stabilità. Nell'ambito del Ferrarese e del contiguo comprensorio
padano del Rodigino, verso la fine dell'Età del Bronzo il corso del fiume si
articolava in due rami principali, il Po di Adria ed il Po di Ferrara, che
sviluppava poi diverse diramazioni nella zona orientale. Il progressivo apporto
di materiali allungava la pianura paludosa e spostava progressivamente verso Est
la linea di costa, attestando successivi cordoni dunosi.